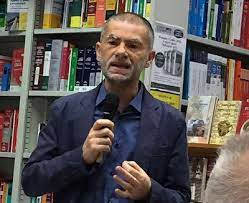Angelo Giubileo-La legge del discreto e l’errore della tradizione
Nella presentazione al nuovo libro di Paolo Zellini, Discreto e continuo. Storia di un errore, si legge: "Fin dall'antichità siamo abituati a pensare il continuo come un primum, un insieme ideale, autosufficiente, ovunque denso e compatto, da cui ogni cosa ha origine. Allo stesso tempo, per ragioni di utilità ed efficacia, accettiamo che quel primum si trovi anche in mezzo ai numeri, e quindi nel discreto. Eppure, afferma Zellini «ciò che conosciamo effettivamente è solo il discreto» e tutto il calcolo moderno si basa sull'informazione insita nelle serie di numeri che approssimano elementi di un continuo che non potremo conoscere mai". Pertanto: un continuo, che è espressione di una fede o credenza e che presuppone l'esistenza di una struttura chiamata tempo.
A partire da una valida ed efficace sintesi di Whitehead, codesta impostazione teorica del processo umano cognitivo affonda le radici in storie e tradizioni millenarie. Così come validamente ed efficacemente dimostrato dagli storici della scienza Giorgio de Santillana e Herta von Dechend, e in particolare nella loro opera monumentale maggiormente nota: "<La nostra scienza è stata fondata sull'ubicazione univoca e sulla concretezza fuori posto>. La fisica moderna ha trasformato questi termini in quesiti. Per Newton la cosa aveva la forza dell'evidenza: <Nessuna persona dotata di capacità di competenza razionale crederà che una cosa agisca là dove non è> (…) Ciò nonostante, la mente dell'uomo civile rimane tenacemente aggrappata a entrambi i principi, ritenendoli in accordo col comune buon senso: tipico caso di un'abitudine diventata una seconda natura. La nascita della fisica sperimentale fu uno dei fattori decisivi di questo cambiamento. Nulla che somigliasse a questo comune buon senso era praticato tanto tempo fa, prima del 500 a. C., quando l'unica realtà era il tempo, e Parmenide non aveva ancora scoperto - o inventato - lo spazio" (G. de Santillana - H. von Dechend, Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo).
Base e supporto di questa concezione fisica della scienza è essenzialmente l'idea del "determinismo causale", fondamento altrimenti noto come <principio di causalità>. In base al quale, ha riassunto il filosofo francese Alexandre Kojève: "nel mondo fisico niente è fortuito, tutto è prevedibile; ogni fenomeno ha una causa che necessariamente lo precede, cosicché, conoscendo la causa, se ne conosce di conseguenza l'effetto; niente si perde, niente si crea, la causa è conservata nell'effetto". E ciò, in base semplicemente a un "comune buon senso", in pratica nient'altro che "una seconda natura" acquisita secondo una credenza e un uso diffusi.
La legge di causalità, secondo i principi d'impostazione della fisica classica, determinerebbe una visione della realtà in modo approssimativo e cioè approssimata a una realtà che in ogni caso i fisici classici ritengano sfugga necessariamente a una determinazione esatta (non è affatto curioso notare come i due storici della scienza appena citati avrebbero avuto l'intenzione iniziale, poi evidentemente ricusata, di titolare la loro medesima opera, L'arte della fuga).
Inoltre, la fisica classica condivide l'ipotesi di una struttura della realtà di tipo "atomistico", suddivisa in "parti", distinte o separate, e quindi una realtà interpretabile in modo discreto, come per l'appunto complesso di cose o enti separati e distinti. Quanto all'"intero", la concezione della fisica classica considera compatibile l'idea che il sistema di "forze" - sostanzialmente quella gravitazionale e quella elettromagnetica - realizzino e diano concretezza a uno spazio viceversa continuo e, per così dire, <infinito> (cfr. G. Semerano, L'infinito: un equivoco millenario).
Diversamente: la fisica moderna - partendo dai principi sperimentati della meccanica quantistica - ritiene, forse con Heisenberg per primo, che la dimostrazione di <ciò che è> sia non tanto approssimativa o approssimata alla realtà quanto piuttosto impossibile. Ovvero: anche se fossimo capaci di misurare esattamente le grandezze o parti di un "fenomeno" - esperienza che la fisica moderna non esclude affatto, anzi in larga parte condivide -, in base alla specifica "posizione" e "velocità" del corpo osservato allo stato iniziale di un fenomeno qualsiasi non saremmo comunque in grado di prevederne gli effetti, e cioè misurare la "posizione" e la "velocità" del corpo osservato allo stato finale di un fenomeno qualsiasi, a causa di ciò che i fisici quantistici chiamano "luce" (in questo caso, l'esatto contrario del detto latino nomen omen). E quindi, l'impossibilità di misurare un fenomeno qualsiasi nella sua interezza.
Ma, passando ora al discorso di Parmenide: cosa significa o rappresenta questa "sua" scoperta o invenzione dello spazio geometrico? Storicamente, la concezione della fisica degli eleati si contrappone alla concezione della fisica classica di matrice stoica, che interpreta la realtà in base alla credenza dell'esistenza del tempo e in definitiva l'esistenza di una sua correlata "struttura" (cfr. Il mulino di Amleto); ciò che finisce per ricondurci alla legge di causalità di cui abbiamo qui detto in forma critica. E allora, in premessa al discorso di Parmenide, ripetiamo che per gli antichi e moderni fisici stoici non esiste alcuna certezza inerente alla determinazione della "cosa" o "ente", quale che sia. La scienza stoica è costruita, come specificato, sul concetto di "corporeità" ma anche sul postulato, assioma o dogma che i corpi siano penetrati dal "pneuma", una presunta sostanza in qualche modo assimilabile al "moderno etere elettromagnetico" (G. De Santillana, Le origini del pensiero scientifico). Insieme, corpo e pneuma, formerebbero pertanto la struttura "continua" della realtà. Estremamente "più complessa rispetto al semplice continuo geometrico di Parmenide" (G. De Santillana, ibidem).
A tale proposito, de Santillana precisa: "La vera concezione di spazio geometrico, una volta formulata, si adatta altrettanto bene a fungere da sostrato sia della forma fisica, in virtù della sua rigidità e impassibilità, sia della materia, se si adotta di essa un'idea che la trasformi in una proprietà accidentale e contingente dello spazio che essa 'occupa'. Questo fu il cammino imboccato da Parmenide, e più tardi da Newton. Non sorprende che egli abbia attribuito un simile colpo di genio all'ispirazione della divinità. Come era naturale per uno che aveva una formazione innanzi tutto pitagorica, fu probabilmente la forma data al problema dei Pitagorici, l'analisi del continuo, a condurlo alla sua scoperta. Il continuo adempie pertanto alla stessa funzione dell'Illimitato anassimandreo – e anche a quella dei numeri pitagorici. Non si può più visualizzarlo come un grande fluire con i suoi mulinelli, o come punti di luce nello spazio irradianti potenza. Non c'è nulla da visualizzare in questo tipo di sostrato; quello che vi mettiamo con l'immaginazione si sfalda in tanti punti, e così all'infinito, finché non appare chiaro che ciò che dobbiamo comprendere è la tessitura, che è poi quella del continuo" (G. de Santillana, ibidem).
In Parmenide, questa idea del continuo non contrasta con l'idea del discreto. Infatti, il Nostro scrive altrove: "Suggerisco pertanto di trattare ovunque la parola <Essere> come termine indefinito, sostituendola in tutto il testo con x (…) Ora, se teniamo la mente 'monda di pregiudizi', come suggeriva Bacone, e cerchiamo di definire x unicamente dal contesto, troveremo che esiste un altro concetto, e solo quello, che può sostituirsi a x senza generare assurdità o contraddizioni, e questo concetto è il puro spazio geometrico stesso" (G. de Santillana, Fato antico e fato moderno).
Ciò premesso, all'interno dello spazio geometrico in questione, una mente nuova - che il fisico Enrico Prati chiama per intenderci più facilmente: "artificiale" - potrebbe percepire la propria visione in modo separato e non continuo, anche indipendentemente da <ciò che è> realmente in natura e, questa è la novità dell'analisi e della ricerca scientifica attuale, al di fuori di una prospettiva che Aristotele ha introdotto con l'uso del termine "meta-fisica".
Scrive Prati: "La cultura moderna ha mutuato il mito della caverna di Platone sotto mentite spoglie riproponendolo nel film Matrix dei fratelli Wachowski (1999), in cui la realtà fisica degli uomini è una gigantesca simulazione proiettata al loro vero cervello mantenuto artificialmente in vita. Anche alcuni filosofi e fisici come Nick Bostrom nel 2003 e James Gates nel 2017 (ma anche io stesso nel 1995) hanno discusso l'idea che la realtà fisica possa essere letta come una simulazione di un gigantesco computer, una visione che non esaurisce la natura della realtà ultima ma che postula la struttura di uno scenario più ampio. Questa concezione consente di ampliare senza contraddizioni di tipo empirico il dominio del mondo fisico a una super-realtà basata su un super-substrato in cui si simula il substrato. Il substrato è percepito come fisico e quindi 'reale' quando è vissuto dall'interno della simulazione, senza contraddizione rispetto al postulare una dimensione metafisica che per alcuni (come Berkeley) è il divino, per altri (come il premio Nobel per la fisica Gerard t'Hooft) è la pura informazione" (E. Prati, Mente artificiale).
E ancora: "Se grazie agli impulsi cerebrali siamo capaci di far muovere braccia meccaniche o di governare un tablet, allora si può provare anche in senso inverso, usare degli stimoli esterni per far fare a un vivente biologico cose il cui controllo è affidato a un computer elettronico (…) Anche qui, la realtà ormai supera la fantasia. Per vedere di cosa sto parlando, potreste visitare (virtualmente) un laboratorio di robo-rat, o robo-topi diremmo noi (ma suona molto peggio). Sanjiv Talwar e John Chapin della State University di New York hanno impiantato degli elettrodi nella corteccia sensoriale dei topi. Gli elettrodi sono stati collegati a uno stimolatore elettrico comandato in remoto in wireless, proprio come facciamo con un'automobilina telecomandata. Uno degli elettrodi era inserito nella zona della corteccia cerebrale responsabile delle sensazioni di piacere. In questo modo è stato possibile addestrare i topi a eseguire comandi dati dall'esterno a fare cose semplici, come andare a destra o a sinistra, salire su una scaletta, ma anche cose che a un topo non piace molto fare, come lanciarsi da una certa altezza. La cosa ancora più sorprendente è che al topolino (o alla topolina …) possono essere indotte dall'esterno sensazioni di piacere e di appagamento, semplicemente attraverso impulsi elettronici (G. Pacchioni, L'ultimo sapiens).
E quindi, per quanto potrebbe riguardare noi ancora-umani, l'induzione statica di una perenne condizione di somma beatitudine, così da attualizzare l'antica promessa, fatta a noi stessi, di diventare "Dio" (Y. N. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro).
Angelo Giubileo
POST IN NEOFUTURISMO blog